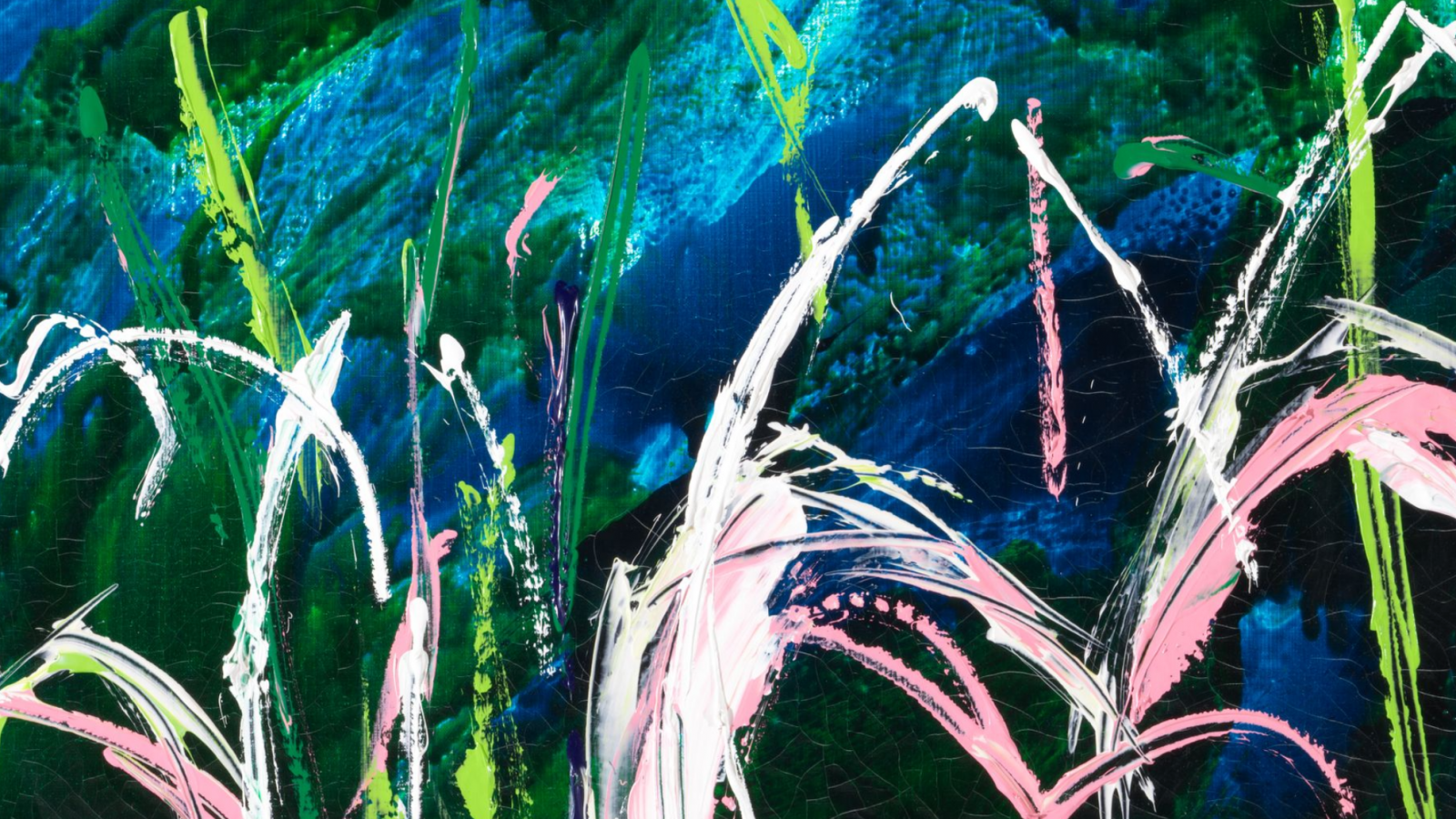Un tempo e un luogo in cui due imprenditori “illuminati”, Cristoforo Crespi e suo figlio Silvio Benigno, sognavano di costruire un villaggio ideale destinato al lavoro lungo le rive dell’Adda. Un progetto urbano autosufficiente e a misura d’uomo, dove operai e artigiani potessero convivere all’interno della loro comunità secondo un piano ideale di ordine e armonia.
In un mondo ben lontano dalla globalizzazione, dove le lunghe distanze potevano essere percorse solo con il treno a vapore, il progetto della famiglia Crespi non fu solamente visionario ma anche rivoluzionario.
Il Villaggio di Crespi d’Adda è un vero gioiello di archeologia industriale. Costruito a partire del 1878 in pieno fermento industriale, fu destinato esclusivamente agli operai e alle loro famiglie, con l’obiettivo di ricreare quel’ “habitat” sociale tipico di qualsiasi altra città.
I lavori iniziarono con la costruzione della fabbrica per la filatura, la tessitura e in ultimo la tintoria; accanto alla quale si ergeva la maestosa residenza padronale in stile medioevale trecentesco, con la sua torre, simbolo del potere della famiglia Crespi.
Negli anni, seguirono la costruzione di una centrale di alimentazione energetica che potesse supportare le produzioni attive e una serie di servizi necessari alla comunità; come la chiesa, la scuola, l’ospedale, le botteghe alimentari e di vestiario e una serie di attività per il dopolavoro e il tempo libero. Un piccolo cosmo sociale ed imprenditoriale in cui i suoi abitanti potevano vivere e al contempo lavorare.
Oltre ad essere all’avanguardia nella dotazione dei servizi, in questa piccola città furono introdotte importanti innovazioni tecnologiche, come l’illuminazione elettrica con il sistema Edison per migliorare sia l’efficienza produttiva che la qualità di vita di operai e impiegati. Ma le curiosità su questo “città ideale” del lavoro operaio non finiscono qui.
Nonostante Crespi d’Adda si trovi in provincia di Bergamo, il suo prefisso telefonico corrisponde a quello di Milano. Al tempo, i Crespi fecero installare una linea privata a lunga distanza che collegava il loro castello con la residenza di Milano.
La scuola, riservata esclusivamente ai figli degli operai, forniva gratuitamente il materiale scolastico necessario all’apprendimento. Lo stipendio e l’alloggio degli insegnanti era coperto interamente dalle rendite della fabbrica. Per non badare a spese, agli inizi del ‘900 fu costruita anche una piscina ad uso esclusivo e gratuito dei dipendenti.
Nei bagni pubblici, dove gli abitanti potevano recarsi a turno per lavarsi, il giovedì era dedicato ai bambini che in quel giorno non andavano a scuola, ma ricevevano un gettone che dovevano consegnare all’insegnante il giorno dopo per attestare che si fossero lavati o meno.
I lavatoi riscaldati erano un altro dei servizi unici del paese: l’acqua calda era a disposizione delle donne, sia in estate che in inverno, e lo stesso luogo fu coperto da una tettoia senza dover andare a fare il bucato al fiume.
E ancora, la Chiesa, costruita in pieno stile rinascimentale, non è originale; ma una copia della Chiesa di Busto Arsizio, città natale dei Crespi.
Le fortune di questo luogo, tuttavia, terminarono nel 2003, quando una crisi economica mandò al collasso l’intero villaggio. Alle 16.52 del 20 dicembre di quell’anno, le campane in città suonarono a lutto e tutti gli operai furono costretti ad uscire per l’ultima volta dai magazzini del cotonificio. Ancora oggi, visitando questo particolare luogo, l’orario è visibile sull’orologio posizionato all’ingresso della fabbrica.
La storia del Villaggio Crespi d’Adda è una storia di lavoro, dedizione e rispetto, che ha rappresentato negli anni, un prezioso modello di riferimento.
Il Villaggio, completato tra Ottocento e Novecento, si trova oggi perfettamente integro mantenendo pressoché intatto il suo aspetto urbanistico e architettonico. Le sue abitazioni, circa cinquanta casette realizzate nel particolare stile inglese, sono oggi abitate dai discendenti dei lavoratori.
Dal 1995, è stato inserito nella lista dei siti Patrimonio UNESCO come “esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del Sud Europa.”