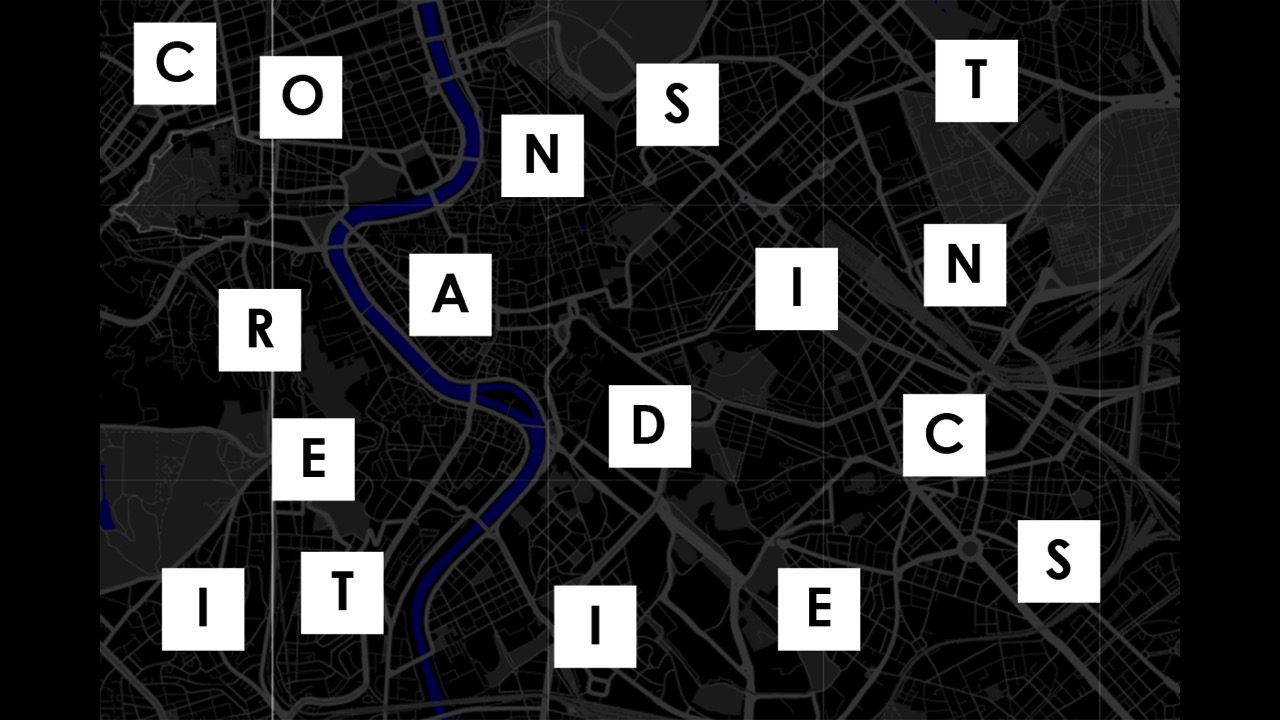Non ricordo bene che anno fosse, ma il posto l’ho bene impresso nella mia memoria: un vecchio casolare nella campagna toscana, a pochi chilometri da dove vivevo all’epoca. Doveva essere più o meno il 1995, l’era del Grunge si era da poco conclusa, iniziavano i miei studi universitari e in quella casa a ridosso di un bosco di faggi nacque uno dei miei più grandi amori: quello per l’opera dell’artista austriaco Hundertwasser, in particolare, per un suo lavoro del 1955: EinRegentropfen, der in die Stadtfällt – Un goccia di pioggia che cade sulla città. Me lo fece scoprire una cara amica, che ormai non vedo da un secolo, mentre sfogliavamo alcuni cataloghi d’arte. Ricordo di averlo utilizzato anche per una raccolta giovanile di poesie, rigorosamente autoprodotta.
Hundertwasser non è di quegli artisti che si studiano molto all’Università, ma la sua visione del mondo, che già a 23 anni lo aveva spinto a volersi “liberare del bluff della nostra civiltà”, come il suo spirito ecologista e l’attenzione per la consapevolezza dell’identità che attraversava tutta la sua vita e opera, conquistarono il mio animo di ventenne. Riguardandolo oggi e rileggendo le sue interviste rimango ancora colpito dal suo essere estremamente di attualità. Nelle sue parole come nelle sue opere si possono trovare elementi e concetti che oggi sono al centro del dibattito sia artistico che politico. Dalla “decrescita felice” allo sviluppo sostenibile. Il tutto realizzato attraverso un serrato confronto con l’opera di Egon Schiele, Walter Kampmann, oltre che con quella di Paul Klee e Gustav Klimt. Ma forte in lui è anche il riferimento all’arte medievale, ai pittori indiani, orientali e africani, come a quelli indios e maori.
Da questi presupposti si generava così un mondo di sogno regolato da proprie leggi che, a tratti, sembra sfiorare quello della musica, mia altra grandissima passione fin da giovanissimo. Quella goccia di pioggia che cadeva su una città ritratta con una prospettiva a volo d’uccello racchiudeva in embrione tutto ciò. La visione ideografica, di ascendenza giapponese, che ci consegnava in questo acquerello su carta da pacchi spiegazzata e preparata con carta copiativa, si sarebbe poi sviluppata nelle sue architetture e in tanti altri progetti dove la centralità dell’acqua come elemento naturale, tranquillizzante e regolatore, è costante come quella del tempo: è la sua corrente che ci trascina, irresistibile, in vortici mutevoli di narrazioni che paiono comporsi per poi scombinarsi e dar vita a nuovi racconti.
In quel momento non potevo saperlo, ma dopo 25 anni mi accorgo che gli artisti che mi colpiscono di più hanno molti tratti in comune con il suo lavoro.
Biografia
NICOLA MAGGI | Giornalista professionista e storico della critica d’arte, classe 1975 è ideatore e co-fondatore di Collezione da Tiffany Srl. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell’arte e di economia della cultura.