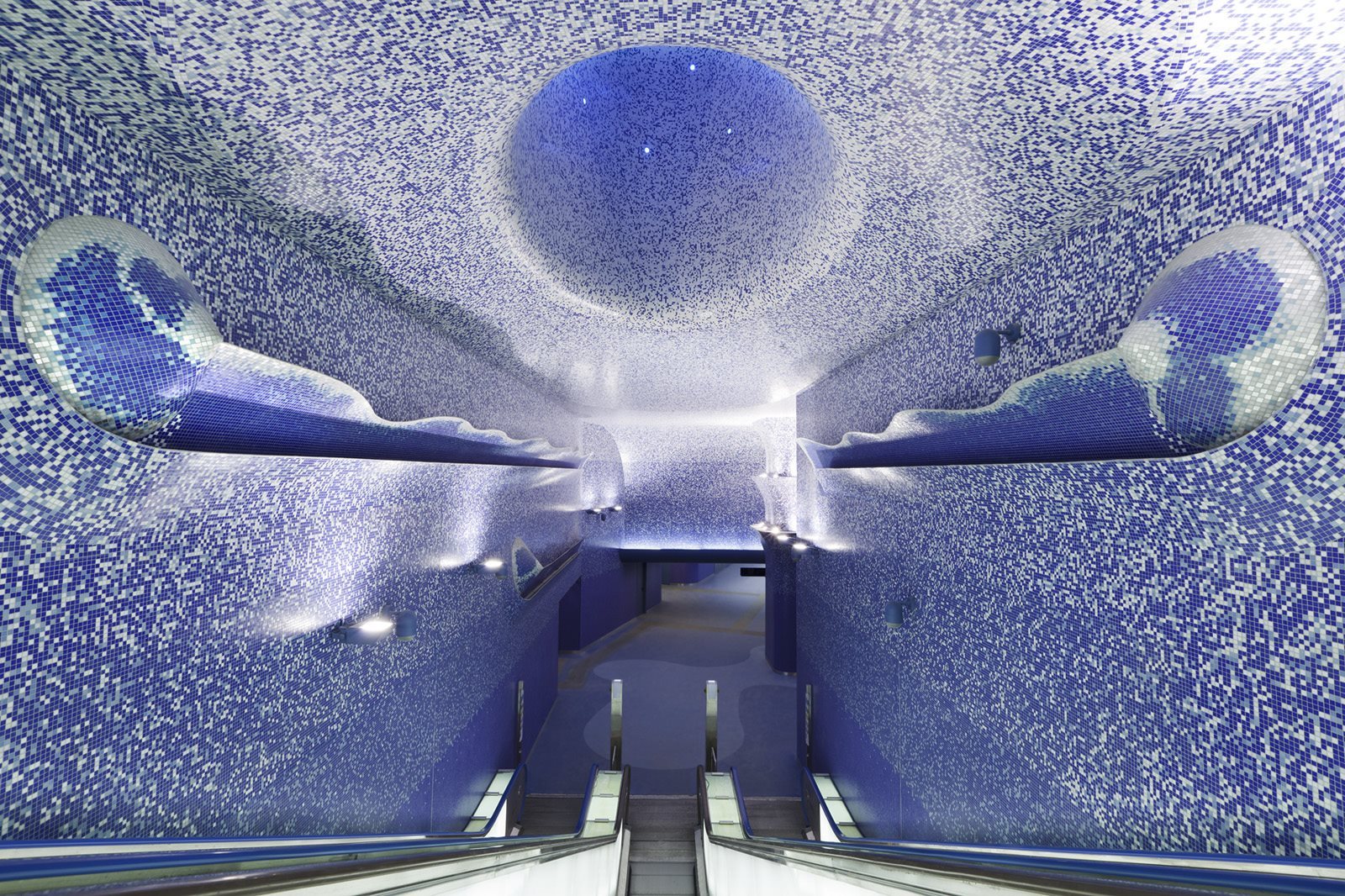Una piccola chiesa di quartiere in una zona poco conosciuta di Trastevere che affascina un gallerista newyorkese, tanto da deciderlo a rilevarla per aprirci uno spazio espositivo.
Questa non è la trama di un film, ma una vera storia d’amore nata tra la Chiesetta di Sant’Andrea de Scaphis a Roma e l’artista prima, gallerista poi Gavin Brown.
Un colpo di fulmine scoppiato da oltre un decennio. Brown, recatosi a Roma in occasione di un’altra avventura artistica, si ritrovò nelle prossimità di questo gioiellino, dalle sembianze un po’ rinascimentali e un po’ settecentesche, e ne rimase totalmente innamorato.
«Nelle vicinanze c’era questo ristorante in cui andiamo ancora e mi sedevo fuori a guardare questo edificio che era all’angolo. È sempre stato l’edificio più suggestivo e magnetico, così semplice, piccolo e ovviamente vuoto» ha dichiarato Brown.
Con una storia da milleduecento anni – la prima pietra risale al secolo VIII – la chiesetta di Sant’Andrea fu sconsacrata per diverse vicissitudini negli anni ’40 e rimase nel totale abbandono fino al 2015, diventando, grazie a Brown, uno spazio consacrato all’arte contemporanea.
Come afferma in un’intervista: «Non avrei aperto a Roma se non avessi trovato questo spazio, per quanto io adori assolutamente Roma. Non è che stavo cercando di aprire un posto in Europa. Stavo cercando di aprire questo posto in questo edificio».
A seconda di come si voglia contare, la chiesetta di Sant’Andrea è il terzo, il quarto o quinto spazio espositivo inaugurato da Brown. La sua carriera come gallerista inizia negli anni ’90 fondando Gavin Brown Entreprises, uno spazio espositivo nel quartiere SoHo di New York. Nel 1999, decide di acquistare Passerby, un bar situato vicino all’allora galleria nel Meatpacking District, famoso per la sua pista da ballo realizzata dall’artista Piotr Uklanski. Nel 2012 stipula un contratto a Los Angeles e apre Mission356, spazio gestito dalla pittrice Laura Owens, che lo stesso Brown rappresentava.
In Europa, in particolare in Italia, la chiesetta di Sant’Andrea non è l’unica galleria “romana” per Brown. Agli inizi del nuovo millennio, esattamente nel 2003, aveva inaugurato RomaRomaRoma, insieme ad altri amici galleristi Franco Noero e Toby Webster, rispettivamente proprietari di gallerie a Torino e Glasgow. Il progetto si concluse nel giro di un paio di anni per impegni collettivi nelle rispettive gallerie.
Brown ama lavorare e sperimentare progetti artistici anticonvenzionali. Il suo intento fin dall’avvio di questa nuova avventura con la Chiesetta di Sant’Andrea era quello di creare un hub artistico in cui poter accogliere esposizioni, performance ed eventi artistici di diversa natura.
Un progetto nato dall’amore per la città eterna nel quale si intrecciano passato e presente e si instaurano relazioni speciali tra gli artisti e lo spazio della chiesetta di Sant’Andrea.
Brown non è il primo gallerista internazionale ad aprire una sede nella città capitolina. Nel dicembre 2007, Larry Gagosian inaugurò Gagosian Gallery la sua settima galleria in un ex edificio bancario vicino a Piazza di Spagna. E a Trastevere, lungo la curva del fiume, negli anni hanno aperto i battenti Frutta Gallery dello scozzese James Gardner e lo spazio Galerie Emanuel Layr dell’austriaco Emanuel Layr.
In ulteriori occasioni, il quartiere trasteverino si sta lentamente confermando come uno dei quartieri di maggiore interesse artistico per galleristi internazionali e non, offrendoci una nuova proposta culturale focalizzata sulla scena contemporanea.